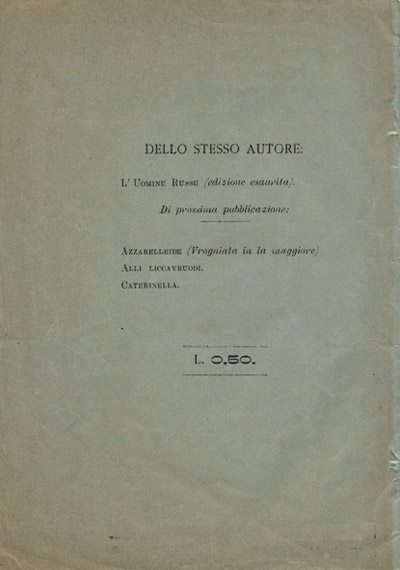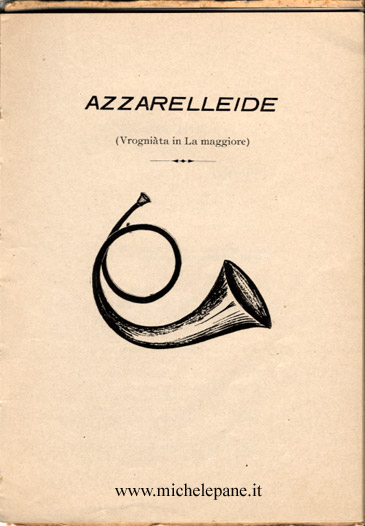Recita alunni Scuola Media a «Domenica in Piazza» – 2004
Scritto on 17 Apr, 2012 in Eventi e manifestazioni | 0 commenti

Ogni tanto capita di ritrovare del materiale risalente a qualche tempo prima ma che vale la pena riproporre a beneficio di quanti non avevano avuto occasione di vederlo a suo tempo.
In questo caso si tratta della recita della poesia ‘A staffetta di Vittorio Butera eseguita dagli alunni della Scuola Media “Michele Pane” di Decollatura, guidati dalla prof.ssa Raffaella Sacco, nel corso della trasmissione Una domenica in Piazza del 23 aprile 2004 che Video Calabria 8 trasmise in diretta da Piazza della Vittoria di Decollatura.
Ecco il filmato:
Alla prof.ssa Sacco, ora in pensione, va il ringraziamento per aver sempre valorizzato il patrimonio culturale del territorio, avvicinando intere generazioni di studenti alle opere dei poeti Pane e Butera.
Agli alunni i complimenti per la disinvoltura con cui hanno affrontato la piazza e le telecamere!
Azzarelleide
Scritto on 5 Apr, 2012 in Azzarelleide | 1 commento

Azzarelleide è un poemetto pubblicato per la prima volta in Viole e ortiche nel 1906 ma era stato composto già da molti anni. Lo testimoniano innanzitutto la pubblicità in quarta di copertina di Trilogia pubblicata nel 1901 in cui si legge «Di prossima pubblicazione: Azzarelleide (Vrogniata in la maggiore)».
Non si è molto lontani dalla verità se si ipotizza che Azzarelleide sia stata composto nello stesso periodo de L’uominu russu con il quale condivide le stesse tematiche e, forse, anche gli stessi personaggi.
In Viole e ortiche fa parte di Ortiche, e quindi si pone nel filone delle opere contro gli uomini malvagi e ingordi, che approfittano della loro posizione per curare i propri affari andando contro moralità e giustizia.
E veniamo al merito dell’opera. Innanzitutto, il titolo. E’ evidente il riferimento ad un’opera epica suggerito dal suffisso -eide che vuole richiamare l’Eneide o forse anche l’irriverente Ceceide di Vincenzo Ammirà. Il personaggio di cui si narrano le “eroiche” vicende è Azzarielllu, quarto figlio nientemeno che di Marte! Pane si riferisce sicuramente a un’altra persona, un uomo in carne e ossa che si vuole prendere in giro — come era accaduto con L’uominu russu — ma di chi si possa trattare è un vero mistero. Forse i contemporanei avrebbero potuto capirlo da qualche riferimento che però ormai è troppo difficile, anzi impossibile, decodificare.
Soffermandosi sul sottotitolo «Vrogniàta in La maggiore» c’è già di che scrivere e approfondire.
La vrogniàta: ma che cos’è? E’ una parola inventata da Michele Pane stesso a partire da vrogna. La vrogna (“brogna” in italiano) è uno strumento musicale primitivo, una grande conchiglia usata come corno. In genere si usava il guscio del Triton nodiferum, un mollusco che arriva alle dimensioni di 30-40 cm, che la mitologia vuole venisse usato da Tritone per agitare o placare le acque. Ne è un esempio la statua della fontana del Tritone di Bernini in Piazza Barberini a Roma in cui Tritone è rappresentato nell’atto di soffiare dentro una «vrogna» detta anche «buccina» (da bocca) dalla quale scaturisce uno zampillo d’acqua.
La vrogna è uno strumento usato originariamente da popolazioni costiere, successivamente passato in uso anche alle popolazioni dei paesi interni. Qui, poi, data la difficoltà di procurarsi la conchiglia, è stato lentamente sostituito da uno strumento simile ricavato dal corno di animali come i bovini che nelle antiche razze ne avevano di giganteschi. Il suono che produce la vrogna è una bassa tonalità che però ha la caratteristica di propagarsi per lunghe distanze, caratteristica che condivide con il corno alpino (quella specie di pipa lunghissima), e tutti gli altri corni usati specialmente nelle montagne come mezzo di comunicazione tra persone (specialmente come segnale di pericolo o dare il via a qualche attività) o per richiamo delle greggi.
Ecco un esempio del suono di una «vrogna» (registrazione del 1961 eseguita a Siracusa):
Un interessante collegamento con la «vrogna» esiste nell’etimologia del nome del paese di Brognaturo, in provincia di Vibo Valentia, nel quale è evidente il nesso tra lo strumento e il nome proprio della località derivato dalla circostanza di essere un luogo in cui venivano pascolati allo stato brado animali (verosimilmente maiali) che poi venivano richiamati con l’apposito strumento (vedi l’interessante studio pubblicato qui)
Suonare la vrogna si dice vrogniare, come faceva il pastore o il porcaro che andavano suonando il corno per le campagne per richiamare e radunare i propri animali. Da qui è nato l’uso figurato del verbo vrogniare che equivale ad «andare a strombazzare» cioè ad andare in giro raccontando ad alta voce cose poco edificanti nei riguardi di qualcuno. Insomma «svergognare», che poi è l’intento di Michele Pane.
La parte I, dopo la dedica, inizia con questi versi:
Mo’ s’ùsanu le trumbe ed è vrigogna
sonare chista marcia ccu’ lla vrogna.
E qui inizia la narrazione delle vicende del personaggio cui è dedicata l’opera, Azzariellu, a partire dai suoi natali fino alle imprese più inverosimili che avrebbe compiuto.
Il nome Azzariellu è il diminutivo di azzaru, “acciaio”, quindi dovrebbe un uomo forte e coraggioso, ma non è così come si vede dalle sue gesta donchisciottesche.
Commentare tutto il poemetto è un’impresa che esula dai fini di questo sito anche perché, come detto sopra, i riferimenti a persone e fatti sono troppo oscuri e nessuno ha mai tentato l’impresa di scavare a fondo nei versi per arrivare a ciò che vi si nasconde. Quel che si può fare qui è fornire un riassunto delle strofe sperando che prima o poi qualcosa in più, oltre il significato letterale, si riesca a decifrare.
AZZARELLEIDE
I
Azzariellu, figlio di Marte, era l’ultimo di quattro fratelli. Il primo si chiamava Spavìentu (Spavento), era veloce più del vento proprio come un uccello rapace.
Ma era avvezzo al vino che preferiva alla lotta e perciò il padre non ne era molto contento.
Il secondo fratello si chiamava Cacacchiu (Fifa) ed era abilissimo nel tiro col fucile. Se andava a caccia, il sangue scorreva a fiumi ma anche di lui il padre era scontento per motivi che non si possono dire (così afferma il poeta).
Il terzo si chiamava Fracassa, grande raccontatore di frottole fin da piccolo e quindi il padre non se la sentì di affidargli il comando delle squadre militari che aveva ai suoi ordini.
E infatti il compito di comandare tali squadre di uomini fu affidato all’ultimo nato, proprio l’Azzariellu cui è dedicata l’opera.
II
Azzariellu dunque si veste d’autorità e al comando della gente che aveva provveduto ad arruolare (suonando la vrogna per richiamare l’attenzione).
Nei versi seguenti Michele Pane descrive le iperboliche dimensioni degli accessori militareschi di cui si dota Azzariellu: spada di un quintale, giberna fatta con la pelle di un’intera cavalla, capace di contenere pane quanto se ne produce in quattro forni, pallottole quanto una braciola (crocchetta), ecc.
Così munito va all’attacco del Drago, un terribile mostro dalle sette teste, che si nascondeva in una grotta nella località Sorbello, una zona nei pressi dell’allora frazione Passaggio di Decollatura.
Il perchè della scelta di questa località è impossibile da comprendere con quanto sappiamo (anzi non sappiamo) oggi.
III
Azzariellu giunge quindi all’ingresso della grotta da dove il Drago, vedendolo arrivare, era già morto dalla paura.
Entra nella grotta il Capitano Azzariellu, pistola in mano, e alla luce della candela accesa dall’aiutante di campo (lo schiavo —scavu— è scritto nei versi) appare il Drago morto per il terrore.
Azzariellu ordina all’aiutante di scuoiare il mostro dopo che egli stesso con la spada lo ha diviso in due.
Quel cuoio servì poi per confezionare una pelliccia per un tale che indossandola acquisisce poteri sovrumani e vince tutte le cause, essendo un avvocato e, forse, anche un politico.
Con questo riferimento esce allo scoperto Michele Pane, rendendo esplicito (lo fa ancora di più nei versi seguenti) il riferimento ad uomini avidi e ingordi, in qualche modo contigui al potere che ha in mano il Comune di Decollatura in quel momento. E infatti, squartando e sezionando la bestia immonda, Azzariellu trova in una piega del gigantesco intestino, nientemeno che un intero edificio, il Municipio! Era stato completamente spolpato dal mostro!
Per portarli in omaggio agli altri suoi amici, Azzariellu fa staccare dal corpo del Drago un orecchio, del grasso per ungere stivali, ecc.
IV
Il successo di Azzariellu non fu però completo. Mancava all’appello il tesoro che tuttora lì rimane protetto da un incantesimo.
Dopo aver preso quel che gli serviva, Azzariellu fece rotolare fuori dalla grotta, giù per il pendio, i resti del mostro e solo rimase nella grotta un grosso dente.
Ed è quel dente che il cane del poeta trovò quando, inseguendo un furetto, si addentrò nella grotta.
Oggi, quel dente aguzzo, “lo uso io” — dice il poeta—. Per pungiglione!
Leggi tutto
Il Presepe di Adami
Scritto on 26 Dic, 2011 in News | 0 commenti

Nell’ambito delle attività per il periodo natalizio, il Parco Letterario-Storico-Paesaggistico di Adami ha allestito un presepe nelle viuzze del centro storico del paese di Michele Pane.
La caratteristica di questo particolare Presepe è che i suoi personaggi, a grandezza naturale, sono dei manichini abilmente costruiti da Ennio Adamo, componente della struttura direttiva del Parco, con materiali di varia natura, soprattutto legno e polistirolo. I personaggi sono collocati in case, magazzini e stalle ormai chiusi da anni ma che per una volta sono stati riaperti e hanno rivisto la presenza degli uomini.
Quelle che seguono sono alcune fotografie prese nel giorno di Natale.
Altre fotografie sono visibili nella PhotoGallery raggiungibile con questo link.
Leggi tutto‘A fòcara
Scritto on 19 Dic, 2011 in 'A fòcara | 1 commento

‘A focara è una delle poesie più famose di Michele Pane, pubblicata per la prima volta in Viole e ortiche nel 1906.
Ma quanti sanno esattamente che cos’è la fòcara?
Innanzitutto, ricordiamo che la parola si pronuncia con la f iniziale aspirata come la “c” toscana di casa o la h inglese di home. Questa particolare pronuncia, oggetto nel passato di molte discussioni su come si debba tradurre nella scrittura, ha spesso portato al grave errore di inserire una h dopo la f (fhocara) o addirittura di usare la lettera h al posto della f.
Questi modi errati di scrivere erano stati già trattati dal prof. Luigi Accattatis nella prefazione al suo famoso Vocabolario del dialetto calabrese e ribaditi nell’appendice a Viole e ortiche (1906) in cui Michele Pane pubblica una nota dell’Accattatis sulla sua poesia. Le parole di Accattatis sono esplicite: «Il delirio di alcuni bravi scrittori calabresi è arrivato fino al punto di scrivere huocu, hidile, hocara, ecc. per rendere il suono aspirato che la labio dentale f ha in Panettieri ed in altri paesi del cosentino, senza nè meno avvertire i lettori che quella h iniziale sta in sostituzione della lettera f, onde è a leggersi fuocu, fidile, fòcara.» (vedi G. Musolino, Michele Pane. La vita, pp. 77-78).
Per quanto riguarda l’etimologia di fòcara, ovviamente all’origine c’è il latino focus, da cui focàra che è una specie di braciere. Il nostro fòcara è usato solo in Puglia, precisamente nel Salento, con lo stesso significato di grande fuoco acceso all’aperto, e in Sicilia. Come curiosità ricordo che focora, col significato di plurale di “fuochi”, è una delle prime parole che compaiono nella lingua scritta cosiddetta del volgare italiano, poichè la usa Cielo d’Alcamo nel Contrasto:
«Rosa fresca aulentissima, ch’appari inverso state,
le donne ti disirano, pulzell’e maritate!
Traimi de ’ste focora, se t’este a bolontate,
perché non aio abento notte e dia
penzanno pur di voi, madonna mia».
Questo stesso secondo verso di Contrasto che contiene la parola focora, è citato da Dante Alighieri nel De Vulgari Eloquentia (I, XII) (riportato nella forma «Tragemi d’este focora se t’este a boluntate») come esempio del pessimo giudizio che aveva della parlata siciliana per la lentezza del ritmo.
Ma torniamo alla fòcara. Si tratta di un grande falò che si accende la sera della vigilia di Natale e che poi viene mantenuto in vita e ravvivato la notte dell’ultimo dell’anno e dell’Epifania. Un grande fuoco all’aperto, quindi, come lo si ritrova nelle tradizioni popolari di molti paesi europei in corrispondenza del giorno più corto dell’anno ma anche in altri periodi.
L’origine della tradizione è certamente pagana, come tanti altri riti e tradizioni che le religioni hanno assorbito e rielaborato, ma qui quello che più interessa è l’aspetto antropologico della fòcara, cioé come è stato rielaborato e vissuto nelle comunità calabresi in generale e in particolare in Decollatura.
La materia prima consisteva principalmente in ceppi di castagno, quasi sempre la parte che rimaneva nel terreno dopo aver tagliato un albero. Si tratta di un intrico di radici in cui rimane molta terra e il colletto del tronco appena accennato. Non si può parlare di materiale di scarto poiché, nei tempi antichi, anche l’apparato radicale degli alberi veniva utilizzato come legna da fuoco, dopo aver scavato il terreno tutto intorno al punto di taglio, che sfiorava il terreno, e, a volte, anche al di sotto. Nessuno si poteva permettere il lusso di lasciare marcire nel terreno qualche quintale di legno in tempi in cui l’unica fonte di combustibile era il legno secco che cadeva dagli alberi dopo un temporale, diritto riconosciuto agli abitanti dei paesi montani sui terreni dei feudatari con il nome legnare a morto, ossia diritto alla raccolta dei rami secchi spontaneamente caduti dagli alberi. C’era poco altro da bruciare: le frasche (fascine di rami secchi), le poche reperibili, servivano per ardere il forno; le stoppie dei lupini occorrevano per le riparazioni annuali del pagliaio; dei tronchi degli alberi, non è neanche il caso di parlarne: chi avrebbe mai tagliato un albero, privandosi di una fonte di cibo? Oltretutto – e ciò sembra inverosimile – il paesaggio dei tempi passati era molto più spoglio di quello di oggi! Nei terreni coltivabili non erano tollerati alberi che, facendo ombra, avrebbero ridotto la produzione del campo e quindi non se ne piantavano, o meglio, c’erano pochi, alti, immensi alberi di pirajina o di melo, tanto alti che la loro ombra si distribuiva su una grande area e quindi dava poco disturbo al raccolto. Non c’erano luoghi incolti in cui potevano essere trovati arbusti o altro materiale vegetale. Gli alberi, i pochi tollerati lungo gli argini dei fiumi o nel bosco, erano potati fino ad altezze inverosimili durante l’estate per dare da mangiare alle capre. Restavano quindi le radici degli alberi abbattuti dalle intemperie, quelli trasportati dalla corrente dei fiumi, quelli i cui proprietari non avevano vigilato abbastanza…
I ceppi, chiamati zucchi in dialetto decollaturese, dovevano dunque essere raccolti lontano, nei boschi o vicino ai fiumi, e trasportati su un rudimentale carro fino alla piazza della frazione di appartenenza dei volontari. Il lavoro necessario per togliere il ceppo con tutte le radici dalla terra e per portarlo a destinazione avrebbe scoraggiato chiunque. Ed è proprio in questo aspetto che, tentando un’analisi antropologica della fòcara, si possono trovare gli elementi per dare un’interpretazione plausibile sulla sua origine e significato. Il punto di partenza è che le radici e la parte di tronco rimasti sottoterra impediscono la lavorazione e la semina del terreno e inoltre, particolarmente nel caso del castagno, non marciscono che dopo moltissimi anni. La cooperazione di tante persone nell’improbo lavoro di estrazione ed eliminazione delle ceppaie di castagno è da considerarsi un’opera positiva poichè una volta l’anno i boschi, e comunque i terreni in genere, venivano ripuliti da queste ingombranti e moleste presenze. Se poi vogliamo andare ancora più indietro nel tempo, fino al medioevo e poi ancora prima, dobbiamo ricordare una delle tecniche primitive di coltivazione: la cosiddetta cesina.
Leggi tutto